Impresa, identita' vo' cercando...
Intervista con Remo Bassetti, autore del libro "L'identità culturale delle aziende", che mette in luce come si è invertito il paradigma impresa-consumatore verso quello impresa-cittadini
Fondatore di Anima in Corporation, società di consulenza per l'identità culturale delle aziende, Remo Bassetti ha intrapreso un percorso formativo di tutto rispetto. Spiegare quale sia il ruolo che l'Impresa, con la I maiuscola, è chiamata a svolgere nella nostra società.
Con il suo ultimo lavoro, "L'identità culturale delle aziende", edito da FrancoAngeli, affronta il tema del successo di un'impresa, tradizionalmente, fondato sulla costruzione della sua immagine esterna. Un approccio che ha raggiunto la massima espressione nella valorizzazione del brand, declinato in differenti espressioni e strumenti.
Tuttavia, è questa la riflessione di Bassetti, la pura apparenza sembra oggi insufficiente di fronte a consumatori che apprezzano e ricercano l'autenticità di un'impresa, la sua capacità di porsi su un piano relazionale e la sua visione del mondo. La grande importanza assunta dalla CSR dimostra che l'azienda, prima di tutto, deve far emergere un modo di essere e che quest'ultimo ne condiziona direttamente il business.
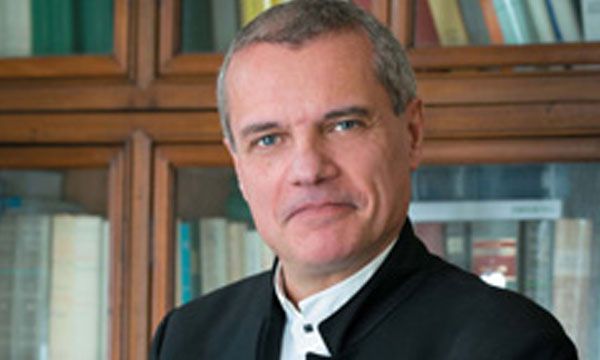
Anche per l'impresa, come per le persone, diventa fondamentale avere un'identità.
Questo libro non solo cerca di spiegare in cosa essa consista, ma ne isola una componente - l'identità culturale - che più di tutte entra in contatto con la percezione affettiva del pubblico. Il volume entra nel dettaglio degli strumenti strategici e comunicativi che l'impresa deve utilizzare per valorizzare il suo percorso di autoconsapevolezza; il testo - che mette in guardia sulle semplificazioni dell'ultima ondata di teorici e pratici della comunicazione, (offuscati dall'effimera ebbrezza dei social, ndr) delinea un quadrato semiotico per pianificare le strategie sul web, analizza il nuovo fenomeno del corporate journalism, i pregi e limiti del buzz marketing e approfondisce i concetti di innovazione culturale e "discorsi sociali". In questa intervista Bassetti approfondisce questioni tuttora aperte nella dinamica relazionale dell'impresa.
L'idea di questo libro parte da un assunto molto interessante. Si è invertito il paradigma impresa-consumatore verso quello impresa-cittadini. Come è nato?
Dopo aver colonizzato l'immaginario imprenditoriale, e persino quello sociale e politico, la figura del consumatore, quale paradigma delle relazioni di scambio, è entrata in crisi.
Sono diversi anni che, sulla scia della critica di Giampaolo Fabris, si cerca quanto meno di riconvertirla, come dimostrano definizioni quali "ConsumAttore" o "ConsumAutore" per indicare un individuo consapevole e niente affatto passivo. Magari c'è una punta di eccesso ottimistico ma non c'è dubbio che il consumatore, nella sua versione idealtipica, non esiste più, e uno dei segnali più evidenti è che, specialmente per alcune tipologie di beni e servizi, egli orienta i suoi acquisti anche in funzione di un giudizio sull'azienda. Non solo il consumatore sta ritornando un cittadino, attento a certe forme di responsabilità, ma egli si aspetta che l'impresa, a sua volta, esprima una capacità responsabile di cittadinanza e di comunità. Sempre più lo scambio economico sarà preceduto da uno scambio sociale. Le aziende dovranno incontrare il loro pubblico fuori dal mercato, in senso stretto, e la reputazione che acquisteranno in quella fase potranno poi spenderla nel business. Quella serie di attitudini sociali, che sono la parte del chi è di quell'azienda che non coincide con la dimensione produttiva e organizzativa, li definisco identità culturale.
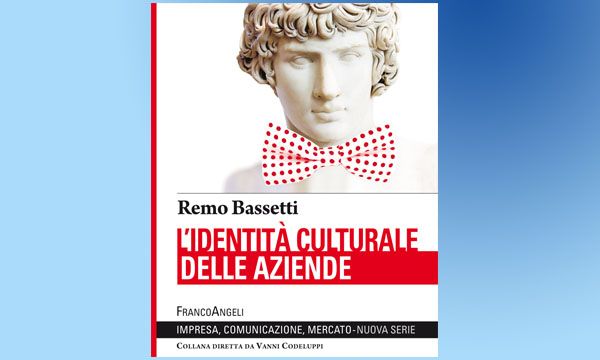
Poche aziende sono attualmente attrezzate per individuarla, svilupparla, rappresentarla.
Quali sono in questa nuova dimensione i rischi che un'impresa deve prevenire?
Storicamente, l'anticamera dell'identità culturale dell'azienda è la responsabilità sociale d'impresa. Quale contraltare a un ventennio di individualismo esasperato, all'inizio del XXI secolo le persone tornano a prestare attenzione alla ricaduta sociale delle singole condotte. Per capire il cambiato nel modo di collocare l'azienda basta leggere come si è trasformata la responsabilità sociale d'impresa secondo la Comunità europea: nel 2001 consisteva nel farsi carico delle "preoccupazioni sociali ed ambientali" verso gli stakeholder, nel 2011 viene identificata come la responsabilità per i "propri impatti sulla società", un contenitore molto più vasto. Il passaggio dalla RSI all'identità è il perfezionamento della presenza sociale dell'impresa: quel che paga non è solo evitare di distruggere la foresta amazzonica o di sfruttare i bambini (che viene dato per scontato) ma avere qualcosa da dire sul mondo, che dia anche un senso più profondo alla ragione per cui si produce.
Lush, probabilmente l'azienda con la più spiccata identità culturale al mondo, si batte contro il TTIP con lo stesso zelo con cui solidifica lo shampoo: non è un valore indiscusso, ma l'azienda sceglie da che parte stare. Ikea ha appena concluso una perfomance collettiva di street art con la vernice ecologica Airline e l'abbinamento con i graffiti serve anche a rinforzare il suo nuovo look di azienda che crede nella libertà espressiva e non solo nel razionalismo funzionale.
Come si misurano i danni che una cattiva condotta può generale nell'impresa?
Il rischio che un'impresa deve prevenire è quello di restare confinata ad esclusivo attore di mercato, e anche quello di focalizzare la comunicazione e il marketing con un senso che nella logica dello scambio di mercato si esaurisce. Ci si domanda oggi se la pubblicità debba lasciare spazio alla comunicazione digitale ma l'interrogativo è posto male: tutti gli strumenti possono ancora essere validi, l'importante è che siano concepiti, oltre che per il prodotto e per il brand, per mettere a fuoco l'identità culturale dell'azienda.
I beni e i servizi si possono imitare e i brand, salvo poche eccezioni, passano di moda, così come gli stili di vita che intendevano ispirare. Ma un'azienda è inimitabile, e nell'ottica dell'identità culturale l'aggiornamento dei valori, dei comportamenti, dei discorsi, delle appartenenze collettive non è un tradimento ma il fisiologico percorso evolutivo e adattivo di un organismo sociale. Quando la condotta di un'impresa appare gravemente scorretta i danni economici conseguenti al calo di reputazione sono visibili a occhio nudo. Le carenze sul piano dell'identità si prestano meno a una misurazione evidente e immediata ma sono più logoranti. Si può però impostare un monitoraggio abbastanza oggettivo su quanto l'impresa e la sua produzione incrociano i discorsi sociali e quanto ne sono ai margini, e trarne un attendibile significato predittivo.
Che ruolo svolgono in questo nuovo trend i social media?
In un recente articolo sull'Harvard Business Review l'autorevolissino Douglas Holt ha denunciato la bolla dei social media dei brand.
Se uno sconosciuto giovanotto svedese che posta filmini amatoriali ottiene milioni di visualizzazioni e il canale You Tube di McDonald's è al novemillesimo posto vuol dire che qualcosa non sta funzionando nel sogno dei brand di essere i media di se stessi. Credo che in effetti le aziende siano rimaste ancorate a una concezione infantile dei social media, con una comunicazione "bruta" (sotto vari profili) del brand, analoga a quella diaristica dell'origine dei social media, oggi marginale persino tra gli adolescenti. I social media sono una fantastica opportunità di comunicare con nicchie variegate di persone che si aggregano intorno a interessi specifici. Ma il brand, o meglio l'azienda, deve accettare di essere un membro, magari molto autorevole, di quelle comunità e non l'oggetto della comunità, salvo i pochissimi che si possono permettere il lusso del contrario. Il resto verrà di conseguenza.
Cosa debbono privilegiare le imprese per continuare ad essere credibili?
Le imprese devono personalizzare le relazioni e produrre discorsi sociali, cioè discorsi che non si limitino al prodotto o allo stile di vita che suggerisce il brand ma che abbiano veramente a che fare con quanto interessa le persone tutti i giorni.
Anche se insisto sulla capacità di apparire extra-mercato, ci sono modi di stare sul mercato che si segnalano per il loro intreccio col significato culturale. Oggi diamo per scontato che l'impresa vincente sia quella che pratica l'innovazione ma pensiamo solamente all'innovazione tecnologica, dimenticando che l'innovazione culturale non è meno decisiva e anzi guida quella tecnologica. Il successo dei social è stato convincere le persone che si può essere "amici" senza mai essersi guardati in faccia. Le aziende che scommisero sulla videotelefonia non riuscirono a introdurre la pratica sociale di tenere vivo il fidanzamento o il corteggiamento a distanza ma guardandosi in faccia. Sorprendentemente la scrittura, della quale tuttora si profetizza la scomparsa, sarebbe con gli sms riuscita meglio nello scopo di rimediare all'assenza fisica. Un'impressionante innovazione culturale.
Titolo: L'identità culturale delle aziende
Autore: Remo Bassetti
Editore: FrancoAngeli
Pagine: 200
@federicounnia - Consulente in comunicazione

